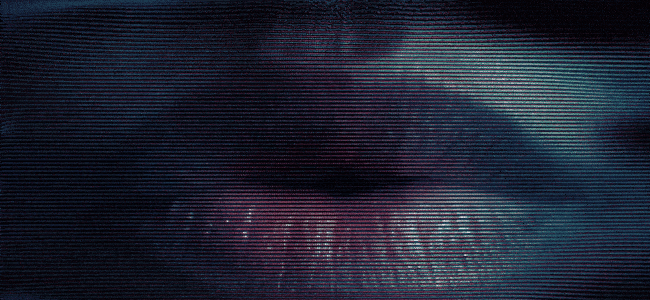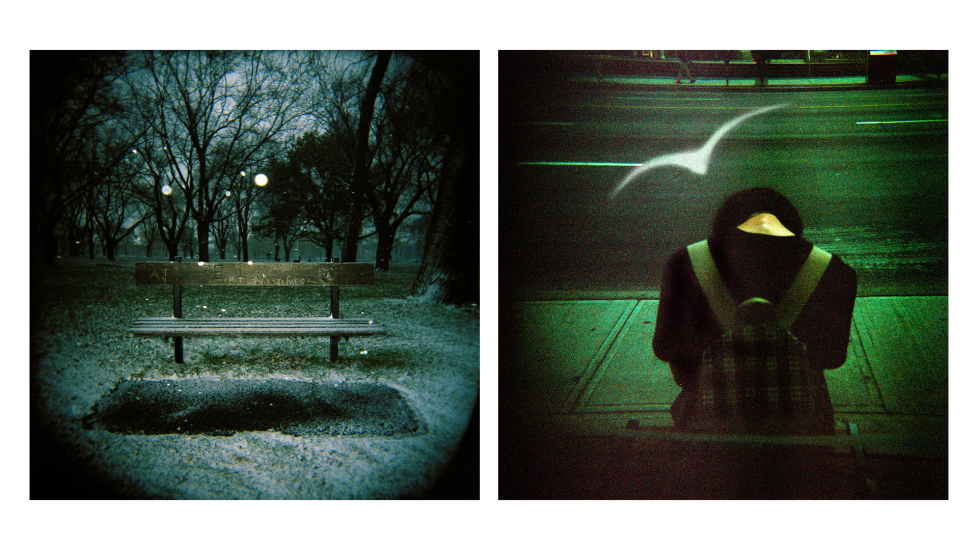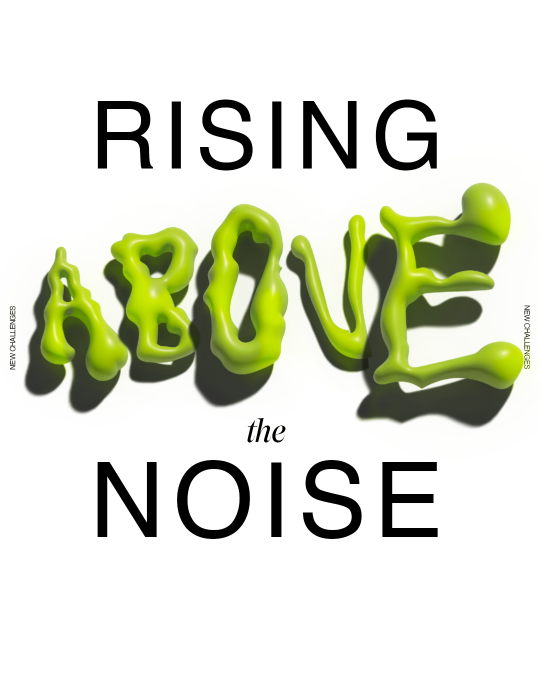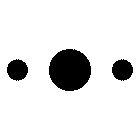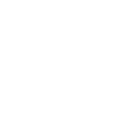Dalla passione per lo skate al lavoro per i brand di alta moda, passando per le fanzine, la fotografia, i viaggi improvvisati, le copertine dei dischi e un incontro a sorpresa con Lou Reed. Intervista al grafico per cui tutto è possibile con la giusta colonna sonora.

Arrivando a casa di Paolo Proserpio, grafico, fotografo, creativo e grande appassionato di musica, ci accoglie Leo, il suo cane, che ci introduce nel suo nuovo studio.
Abbiamo scelto di incontrare Paolo e fargli qualche domanda per tanti motivi, il primo – e forse più futile – è che le sue serigrafie sono gli unici quadri appesi in Blossom. E sappiamo di non essere gli unici ad averle apprezzate…
D. Immagino che siano in tanti negli ultimi tempi a dirti: “Ho visto una tua serigrafia in casa dei Ferragnez. Ma ti sei venduto?”. Tu, che fai questi lavori da tanti anni, cosa rispondi?
R. Rispondo che io non so come ci sia arrivata una mia serigrafia a casa loro (potrebbero averla presa da Le Grand Jeu a Parigi, ma non ne sono sicuro!), ma aggiungo anche che, se delle persone che potrebbero avere in casa un Keith Haring o un Berry McGee o qualsiasi altra cosa scelgono una mia serigrafia, io sono contento. E basta.

D. Dopotutto tu hai sempre unito mainstream e cultura underground, giusto?
R. Sì, per me non è mai stato un problema o un limite. A chi è super purista non ho nulla da dire. Io però non la vivo come una contraddizione. Per tanti anni ho lavorato da Versace e, contemporaneamente, facevo le copertine di dischi indipendenti e scattavo foto ai gruppi per delle riviste della scena musicale underground e non.
D. Ecco, a questo proposito, come sei passato dalle copertine dei dischi punk degli amici del liceo agli inviti delle sfilate di alta moda?
R. È tutto collegato, è una lunga storia che inizia negli anni Ottanta.
D. Ce la racconti?
R. Sì. Tutto comincia nel 1989 con Ritorno al futuro. Parte seconda. Nel film il protagonista Marty va in skate, io lo vedo e voglio andare in skate anche io. Ma a Desio (ndr: una cittadina di provincia in Brianza, paese di origine di Paolo) non c’è molta gente che lo fa. Poi un giorno, mentre sono in giro con lo skate, vedo per strada uno con la tavola e lo inseguo. E lì inizia tutto.
D. Che cosa inizia esattamente?
R. Scopro che esiste un giro di ragazzi che non ascoltano per forza Jovanotti o i Guns’n’Roses o Vasco Rossi. Scopro un sacco di cose bizzarre e persone freak, conosco i fratelli Formenti di Seregno, che facevano un magazine di skate (di cui oggi custodisco ancora delle copie). Scopro gli adesivi, le grafiche delle tavole, il punk e il rap… Mi si apre un mondo.
D. Una comunità in cui finalmente ti riconosci?
R. Mah, sì… però non mi fraintendere, non sono “Jenny from the Block”, non è che arrivo dal ghetto (ndr: ride). La mia è una famiglia normalissima e io non ho mai voluto ribaltare il sistema… È solo che per me lo skate, da subito, ha significato un’enorme libertà.
D. E come passi poi alla moda?
R. Eh, allora… qui ci sono tre passaggi fondamentali: la scoperta ufficiale del lavoro del grafico, le foto ai concerti e il Coachella.
D. Sembra interessante. Partiamo dal primo punto: perché fai il grafico.
R. Stavo facendo l’Accademia di architettura a Mendrisio, in Svizzera, senza nessun entusiasmo, e la mia “santa mamma” – che è viva, eh? No, perché quando dico così mi fanno tutti le condoglianze…– un giorno mi dice: “Ad architettura ti hanno segato a mille esami… Non è che quelle cose lì dei dischi, che fai fino alle 5 del mattino, sono il lavoro che vuoi fare?”.
In effetti era vero. Avevo iniziato a fare disegni e collage per dischi e flyer, e in quelle cose mettevo una passione incredibile. Ma non sapevo che si chiamasse “grafica”.

D. In che senso?
R. Nel senso che poi sono andato allo IED per iscrivermi, ho preparato un po’ dei miei lavori e mi sono presentato come illustratore. Ma loro mi hanno detto che quello non era illustrare. Insomma, mi hanno instradato e mi hanno un po’ salvato.


D. E le foto ai concerti quando arrivano?
R. Le foto arrivano presto, quasi subito. Ma diventano un lavoretto quando mio papà mi regala la Mavica della Sony, una delle prime macchine digitali, quella che funzionava con i floppy. Ce l’ho ancora! Con quella scattavo foto a ogni concerto e la mattina dopo le mandavo alle testate. È così che ho iniziato a collaborare con Rumore, Rockstar, Rocksound, un’agenzia fotografica americana (Retna) e anche MTV…
D. Tu lo chiami lavoretto ma in realtà hai un archivio di foto con alcuni dei più grandi protagonisti della musica degli anni Novanta e Duemila. Hai uno scatto preferito?
R. No, uno preferito forse no. Però ho tanti episodi assurdi che stanno dietro quegli scatti. Ad esempio, nel 2004 ero al Festival di Benicassim e mi scappava la pipì da morire. A un certo punto vedo una porta con scritto “non entrare” e penso che di sicuro lì dentro c’è un bagno. Così la apro e, quando entro, trovo Lou Reed da solo, in mezzo a una stanza con tantissime sedie e basta. Sembrava una performance! Io vado, scatto una foto e subito quello della sicurezza mi manda fuori. Insomma, cercando il bagno ho scattato una foto di Lou Reed in primo piano…
D. Oltre alle foto, fra le tue tappe fondamentali, hai citato il Coachella. Perché?
R. Eh sì, perché mentre ero all’ultimo anno di IED, nel 2002, la mia carissima amica Cristiana Paolucci (a.k.a. Nanà) – che lavorava per MTV e che oggi, purtroppo, non c’è più – vuole andare al Coachella per gli Strokes. Io subito dico: “No, ho la tesi adesso, non posso venire”.
Lei, invece, che cosa fa? Mi prenota un volo e me lo dice tre giorni prima… Ovviamente sono partito con lei. Dopo una serie di peripezie, fra cui il fatto che non avevamo gli accrediti, siamo riusciti ad entrare e lì ho passato tre giorni pazzeschi.
Oltre ai concerti, ho visto Vincent Gallo, abbracciato Tim Burgess dei Charlatans, sono stato al bar di fianco ai Chemical Brothers…

D. E cosa c’entra tutto questo con il tuo diventare grafico per la moda?
R. C’entra perché, mentre ero via, scopro di essermi perso i colloqui che Versace aveva fatto agli studenti dello IED. Quando me lo riferiscono penso: “Nessun problema. Li chiamo”. In quel momento ero carichissimo. Cioè, io ero stato al Coachella, avevo visto Bjork che suonava insieme ai Matmos con il pancione (aspettava sua figlia Ísadóra, figlia anche di Matthew Barney!), capisci… Ero così sicuro che mi hanno preso.
D. Che cosa hai scoperto quando hai iniziato a lavorare come grafico per i brand?
R. Durante la mia prima esperienza nel magico mondo della moda, nel 2001, a Londra, da Gucci (con Tom Ford), ho scoperto che non potevo prendere i pennarelli e graffiare il logo solo perché piaceva a me. Che se mi piaceva il grigio non potevo fare tutto grigio. Ho imparato che dovevo capire i valori e temi del brand. Nel 2002 ho cominciato a lavorare per Versace e, nonostante tutti questi anni dedicati alla mitica Medusa, come potete vedere, non sono assolutamente un uomo Versace: non ho i vestiti zebrati, il barocco… Ma non importa, ho imparato ad amare il brand per quello che vuole esprimere, a guardare, a vedere un sacco di cose diverse e ad affrontare lavori complessi, con produzioni gigantesche e su scala globale. Ho imparato ad accettare le sfide.
D. E come convive questo mondo con la tua produzione personale?
R. Convive benissimo. Perché un giorno fai il catalogo tutto in stile barocco per la moda e, dopo tre ore, fai, non so… un disco di un gruppo che fa musica jazz sperimentale. E non ti annoi mai. Ed è mescolando tutta questa roba che poi scopri che certe cose ritornano. Perché alla fine tu sei sempre tu e, quando poi vedi certi lavori vicini, capisci che hanno la stessa mano: la tua.
La gente si immagina che, se lavori da Versace, la sera sei in giro con dieci modelle a drogarti, quando in realtà sei a passeggio a Desio con il cane. O almeno, questo sono io.
D. Però la tua vera passione resta sempre la stessa?
R. Le cose che ho tentato di fare di più sono i lavori legati alla musica, perché davvero non c’è niente che amo di più. È la mia passione, lo scheletro su cui si muove tutto. Per me tutto è arrivato da lì e lì torna. Quando sento un disco, io so esattamente che copertina ha. Perché la musica c’è sempre, ma per me c’è sempre anche un vestito. E certi gruppi ammetto che mi piacciono anche per il loro contorno: per come sono fatti, per come si muovono, come si vestono, per il merchandise che fanno, come allestiscono il palco, che foto si fanno fare… Ecco io adoro fare parte di questo, adoro dare un’immagine alla musica.


D. E perché scegli spesso artisti indipendenti?
R. Io non sono di quelli che dicono: “Se sei famoso, mi fai schifo”. Non è che se fai un concerto a San Siro non mi piaci più. Però gli artisti underground hanno un grande vantaggio: sono liberi. Non hanno pressioni o vincoli. Sono freschi, fuori controllo. Possono fare quello che vogliono, a volte dicono cose comuni, a volte fastidiose, a volte incoscienti. E questo per me è una figata. Perché poi dagli artisti, dagli illustratori, dai grafici indipendenti trovi ispirazione anche da portare nel momento in cui lavori per un grande brand. Faccio un esempio: tu vedi, che ne so, una pubblicazione indipendente che è piegata in un certo modo, la vedi fatta a mano e poi tenti di trasferirla in una produzione in larga scala dove magari la puoi anche migliorare.
D. La concretezza è un tuo punto di forza. Sei sempre stato molto materico. So per esempio che le copertine di alcuni dischi le hai piegate a mano, una per una. E poi, qui non hai solo il computer, ma è pieno di strumenti.
R. La matericità arriva sempre dallo skate: con lo skate cadi, ti fai male, monti e smonti la tavola e le rampe. E poi mio nonno era un falegname, mio papà ha fatto l’idraulico tutta la vita. Tutte le prime rampe da skate le ho fatte con mio papà. Quindi la fisicità secondo me arriva da lì.
D. Ed è per questa esigenza di “muovere le mani” che hai iniziato a fare serigrafie?
R. Ho iniziato a fare le serigrafie perché lavorare per i clienti è bellissimo però, a volte, anche no. A volte è bello fare senza brief, fare cose che siano fuori controllo. Della serigrafia mi piace tantissimo il fatto che con il colore produci una grafica in serie, in cui però c’è sempre l’imprevedibilità dell’errore.
D. E come hai imparato a farle?
R. L’interesse è nato quando volevo stampare magliette e poster. Nel 2004 sono andato a San Francisco e Chuck Sperry di Firehouse mi ha spiegato tutto sulla poster-art e la serigrafia. Poi per dodici anni tutte le estati ho seguito dei workshop alla Central Saint Martin School Of Art a Londra, dove fanno corsi legati alla stampa, corsi di serigrafia basica su carta e tessuto. Ma anche “Preparazione avanzata dei telai serigrafici” presso la East London PrintMakers… Insomma, robe molto nerd, a cui eravamo iscritti in tre.

D. Questa necessità di esprimersi liberamente è un atteggiamento che potremmo definire da artista. Come reagisci se ti chiamano così?
R. Artista no, non mi ci sento. Potrei dirti che c’è dell’artisticità in quello che faccio, al massimo. Per me uno che fa l’artista è uno che non deve giustificare in nessun modo quello che fa, uno che fa una statua di wurstel e se ne frega del fatto che marcirà o se piacerà o meno.
Per chi fa comunicazione è diverso.
Io ad esempio mi sento libero, ma nella mia mente è come se fossi il cliente di me stesso, perché tento sempre di darmi una spiegazione. E, comunque, l’unico che mi chiama “il grande artista Paolo Proserpio” è Auroro Borealo!
D. Fra i tanti incroci della tua vita c’è anche Blossom.
R. Sì, Giacomo (Frigerio) è un mio coetaneo. Abbiamo frequentato per tanto tempo le stesse realtà, eravamo nel giro punk rock. Ai tempi non c’era internet e ti vedevi sempre agli stessi concerti: noi avevamo gli stessi interessi e pian piano ci siamo conosciuti. Oggi ammiro il suo coraggio: ha costruito una cosa grande, con tante responsabilità.
D. Come saprai, il purpose di Blossom è “We fight for Beauty, to make the world a better place”. Che cos’è per te la bellezza?
R. Per me il bello e il brutto universale non esistono, sono una cosa che evolve, anche di giornata in giornata. Ti faccio un esempio: se adesso questo lampadario, che mi piace tantissimo, cade e ti uccide, probabilmente quando lo rivedrò dirò: “Questo lampadario mi piace un po’ meno”, no? Poi magari fra vent’anni mi dimentico che ti ha ucciso durante l’intervista e dico: “Però, sai che ‘sto lampadario è davvero figo?”. Ecco. Questo vale anche per le città, per i cibi, per i dischi… Perché il gusto evolve! Pensa a quando vediamo le nostre foto di vent’anni fa e diciamo: “Guarda come ero vestito male!”. Oppure quando pensi a dei gruppi che ascoltavi quando eri teenager e dici: “Ma che merda era?!”.
Poi, se una persona la cosa più creativa che ha fatto nella vita è vedere il Grande Fratello Vip, penso che, in qualsiasi cosa che penserà o produrrà, purtroppo, pescherà solo da lì, e quindi il risultato avrà dei limiti. Questo per dire che secondo me il bello arriva quando hai delle contaminazioni, che vuol dire anche semplicemente che hai osservato e assimilato tanto. E, quindi, quello che produci si capisce che ha qualcosa dietro, una ricerca, qualcosa di profondo che poi, di fatto, è tutto il tuo bagaglio culturale.
D. E tu come rinnovi il tuo bagaglio culturale?
R. Mi piace guardare un sacco di cose, a volte anche per capire che non vanno fatte. Poi non so, se vedo un telefilm e compare un titolo iniziale che mi piace, me lo segno facendo una foto con l’IPhone. Poi ci sono cose che guardo più spesso perché ne sono mega fan. Per esempio, Art Chantry mi piace tantissimo: è un grafico che fa dei packaging assurdi, dove la parte analogica è fatta a mano e molto presente. È quello che ha fatto Louder than love dei Soundgarden, ha lavorato per The Mono Men, Sonics, Mudhoney per SubPop ed Estrus Records. Io vorrei tantissimo andare a incontrarlo a Seattle. Però ci sono anche altri che ammiro: Vaughan Oliver (scomparso nel 2019, con cui ho fatto un workshop a Londra) Stephan Sagmeister, Robert Beatty, Swifty, Broken Fingaz, David Carson, M/M Paris…


D. Da oltre 20 anni sei docente allo IED. Cosa consigli a chi vorrebbe fare il… designer o grafico? Tu quale definizione preferisci?
R. Io preferisco dire grafico. Perché il designer mi sembra sempre una persona che fa degli oggetti tridimensionali, tipo una sedia o una borsa. Invece il grafico mi riporta più delle cose piatte…anche se il packaging poi non è piatto, però… Be’, preferisco grafico.
D. Allora, cosa consigli a chi vuole fare il grafico?
R. Come prima cosa, uno deve essere coraggioso e capire se ha veramente voglia di fare questo lavoro. Se è disposto a tutto per scoprire cose nuove, se compra libri, naviga per ore, cerca su Instagram… Ma non perché se lo impone, perché quella è la cosa che gli piace fare di più, perchè ha una sete pazzesca di tutto quello che succede in questo settore!
E poi, consiglio di cominciare a sporcarsi le mani subito. Quindi: tua cugina ha la pizzeria e ti chiede i biglietti da visita? Falli. E mi auguro che tu li sbagli tutti e capisca l’errore che hai fatto, così quando li farai per Nike saranno perfetti. Perché con pochi strumenti si possono fare cose fighissime, e sulle cose piccole si può sempre sperimentare, si è più liberi… Ma questo l’ho già detto prima… Va be’, sono andato lungo, scusate. Andiamo a fare un piatto di pasta?
E così ci spostiamo in cucina. E prima di mettere l’acqua a bollire, Paolo fa partire Milano, il disco di Daniele Luppi & Parquet Courts, e ci porta i cataloghi della sua mostra di foto Thank God I’m a Graphic Designer, 1999-2009. Ten years of rocknroll photos. La musica va, lui cucina, noi ripercorriamo i migliori concerti degli anni Novanta e Duemila, e pensiamo a quanta passione serva per “non essere un artista”.
Tutte le foto di questo articolo sono state scattate per Blossom da Ray Banhoff, scrittore e fotografo cresciuto in Toscana.
Per conoscerlo: questa la sua newsletter; questo il suo profilo Instagram.
E questo è il profilo di Paolo Proserpio.